At 10,25-27.34-35.44-48
Sal 97
1Gv 4,7-10
Gv 15,9-17
La VI Domenica di Pasqua ci propone la seconda parte del discorso della vite (15,9-17). Ritmato dal tema dell’amore, il passo è inserito tra i discorsi di addio (dal cap.13): l’uso del tempo presente e del VOI interpellano tutta la comunità credente ad una progressiva conoscenza di Lui, attraverso la fede e il dono dello Spirito.
Il passo comincia col movimento che dall’amore di Padre (v. 9) va sino all’amore condiviso tra fratelli (v. 12): il Padre è l’attore principale di una relazione d’amore con il Figlio tutt’altro che esclusiva: l’aggettivo he emè in posizione enfatica, a differenza del semplice mou (v. 10), ci aiuta a percepire questa provenienza. L’amore del Padre procede e, abitato dal Figlio, viene proposto ai suoi. Da questo dinamismo scaturisce la risposta del Figlio e dei credenti all’amore ricevuto (v. 10). Questa “cantata dell’amore divino” (Lèon-Dufour) si esprime nell’amore che essi si donano reciprocamente. La sequenza sembrerebbe culminare nell’esigenza di dare la propria vita (1Gv 3,16). In realtà l’oggetto della contemplazione dell’evangelista è l’assolutezza dell’amore di Gesù per i suoi. Il Magistero della Chiesa ce lo ha ricordato raccontandoci la Rivelazione (DV2): non una trasmissione di verità a cui dare l’assenso ma un’auto comunicazione di Dio. Non ci dice solo delle cose, ci da se stesso, nel Figlio. Il suo amore motiva l’offerta della propria vita. Ecco, la conoscenza del Figlio è prima di tutto una rivelazione continua del suo amore per noi e non solo una ricerca iniziatica attraverso il lavoro interiore.

L’amicizia con Cristo non può equipararsi ad una armonia psicologica (come ad amici DV 2; Es 33,11) C’è di più. Si tratta di una relazione obbediente dunque libera. Tutta la storia della Salvezza è un cammino lento e progressivo di liberazione (Gn 18, 16-19; Sal 105,6; Is 41,8; Rm 4; Gal 4, 21-31). Ma liberazione da cosa? Quanto più rimaniamo legati alla nostra natura originale, alla nostra debolezza, alla nostra schiavitù al peccato, tanto più avvertiamo un senso di servitù nei confronti di Dio. Un continuo esercizio di obbedienza col quale progrediamo nell’amicizia col Signore. Attraverso l’ascolto, il capire e il decidere consapevole, noi rimaniamo amici liberi, creativi e dinamici, umili cioè fedeli al reale. Umili e non avviliti. L’avvilimento, quando cioè ci sentiamo indegni dell’amicizia di Gesù, è segno che in fondo pensavamo possibile esserne degni.
Potremmo interpretare il frutto del v.16 con il successo della missione apostolica, attraverso la predicazione nel ministero istituito. Lo confermerebbero i verbi eklègomai (già impiegato per la scelta dei Dodici (6,70; 13,18), e tìthemi (stabilire). Eppure nel quadro successivo la scelta di cui Gesù parla non è quella di alcuni tra i membri della comunità, ma della comunità in tutti i suoi membri (cfr. LG10), in opposizione al “mondo”. Lo stesso tìthemi potrebbe introdurre un concetto di portata più vasta che un ministero particolare. Il rimanere giovanneo non può coincidere col frutto ma, come ogni segno, rinvia a qualcos’altro. Lo si intuisce dal contesto. Già l’amore reciproco rivela l’origine del Figlio (13,34); così come la preghiera nel nome di Gesù nel segno di “opere più grandi” (14,12-13). Pur evocando frutti che, secondo Ezechiele non verranno meno (47,12), il frutto che i discepoli dovranno portare è alla fine quello che attraverso di essi porta il Risorto (1Ts 5,10). Si, nel versetto più che un appello ne intuiamo la promessa! Colui che rimane è colui che sa di essere amato. E di questo amore si fa testimone.
Francesco de Leo, V anno
Diocesi di Molfetta

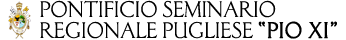
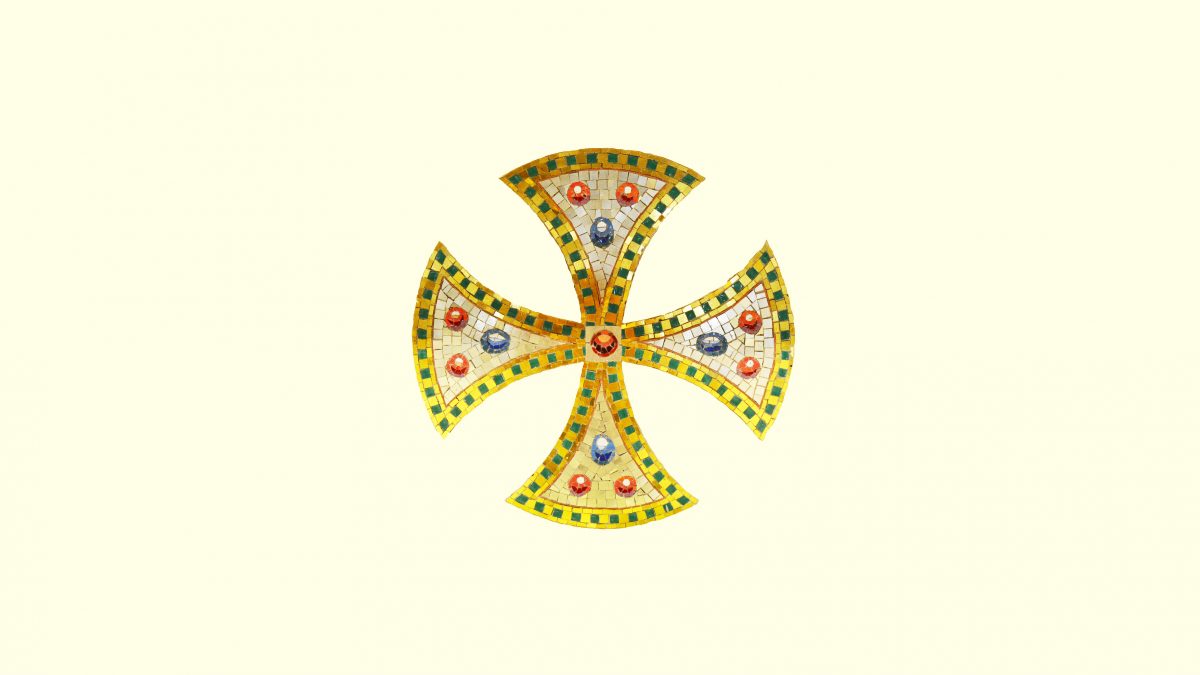


Commento al Vangelo della IV domenica di Quaresima
Leggi più...